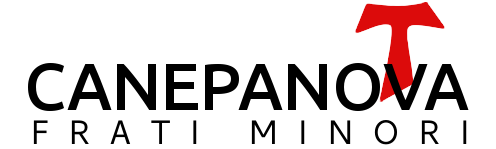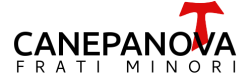La più dolce eresia
- Visualizza in Home: No
Emily Dickinson si muove nel clima di una famiglia di tradizione puritana dell’America di metà Ottocento e ha una vita trascorsa nella casa paterna “tutta chiusa”, fatta di poche amicizie, molta solitudine, due amori “romantici” e impossibili, destinati a non concretizzarsi.
In questo breve testo, ironico, e forse, come lo definisce lei, “eretico” prova a definisce il rapporto tra uomo e donna come una “celebrazione” laica di reciproca conversione e di affidamento l’uno all’altra. Afferma che dalla reciproca conversione nascerà grazia e “infedele” è chi mancherà a questo rapporto.
È intenso questo sentimento, pienamente umano, di reciproca consegna, che diventa quasi un rituale religioso (le chiese allora sono i luoghi dove uomini e donne si incontrano), che vuole raccontare il rapporto di una coppia quasi come un rito religioso, che si gioca però sulla “dimensione orizzontale e paritaria” (e per questo è “una dolce eresia”).
Quanto può essere profonda l’intensità umana nella reciproca accettazione all’interno del matrimonio; Piace che l’autrice voglia leggere una “sacralità di due” in una dimensione tutta umana.
Ma è anche tipico della Dickinson porre quasi in conflitto il rapporto dell’amore umano rispetto a quello dell’amore di Dio. Il rapporto di E. Dickinson con Dio nelle sue poesie è sempre giocato tra l’affidamento e il dubbio alla bontà di Dio. I due amori (quello umano e quello di Dio) sono in continua tensione dinamica e non trovano spazio l’uno nell’altro ma piuttosto continuano a essere posti l’uno di fianco all’altro.
Ecco allora che una provocazione suscitata dal testo: nei momenti in l'amore di sposi si trova davanti al conflitto, all’irritazione, alla richiesta di perdono, riesce ad essere un rapporto “dentro il cuore di Dio” o continua a stare accanto al modo in cui Dio ama? E se sì, come lo si riesce a gestire? È una tensione? Quando invece si sperimenta il conflitto vissuto "col cuore di Dio" come lo può raccontare?
- Creato il .
- Visite: 3841